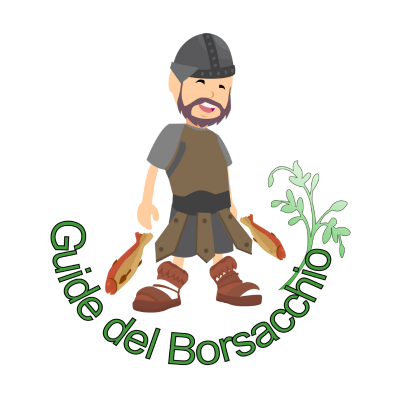Senatore Giuseppe Devincenzi
Senatore Giuseppe Devincenzi
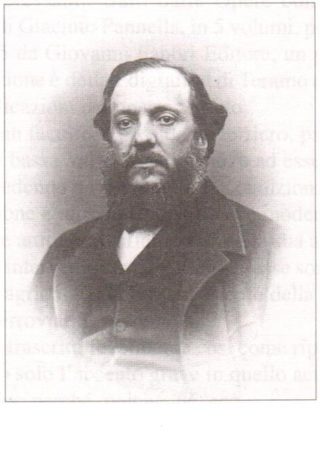
DEVINCENZI, Giuseppe. – Nacque a Notaresco (Teramo) il 4 marzo 1814, in una famiglia della borghesia agraria con vasti possessi nel Teramano. Dopo gli studi secondari nel collegio di Teramo, a venti anni andò a Napoli, dove seguì i corsi universitari di scienze naturali, filosofia e diritto, e la scuola privata di lettere di B. Puoti. Uno dei suoi primi scritti (1836) sulla “nuova filosofia del Royer-Collard e del Cousin” ha meritato l’attenzione di G. Gentile. Tuttavia, anche per la sua posizione economico-sociale, i suoi interessi furono presto attratti dai problemi dell’agricoltura, pur non trascurando “la scienza della pubblica amministrazione”. Partecipò alla sesta Riunione degli scienziati italiani, tenuta a Milano nel 1844, impegnato nella sezione di “agronomia e tecnologia” con una relazione sulla “agricoltura milanese”, che giudicava la più evoluta e le cui tecniche avrebbe voluto vedere adottate anche nel Meridione.
Il primo impegno pubblico del D. fuquale rappresentante di Teramo nell’Assemblea napoletana, i cui comizi erano stati affrettatamente convocati il 18 e 30 apr. 1848 da re Ferdinando II.
Si schierò con la parte più aperta della Camera allorché, da poco giunto a Napoli, apprese che i deputati ed i pari, all’apertura del Parlamento, prevista per il 15 maggio, avrebbero dovuto giurare la costituzione con una formula che non faceva alcun cenno alle modifiche da apportarsi alla costituzione stessa. Il nome del D. appare poi fra i firmatari della protesta stilata dal Mancini contro l’intervento della truppa che intimava ai deputati di lasciare la sala di Monteoliveto, dove si erano riuniti.
Nel periodo successivo – dopo che il 10 luglio era stato nominato fra i quattro segretari della neoeletta Assemblea – si adoperò affinché alcuni principi qualificanti del costituzionalismo venissero recepiti dalla prassi parlamentare napoletana: il 12 agosto firmava la proposta Pica sulla responsabilità dei ministri e dei funzionari; il 2 settembre svolgeva un’interpellanza di politica estera in cui poneva con forza il principio del reciproco controllo dei poteri costituzionali, incontrando l’ostilità della stessa Camera timorosa di una possibile prevaricazione governativa nei propri confronti; ne riceveva l’approvazione, invece, allorché – di fronte alla minaccia ministeriale di convocare nuovi comizi – si faceva assertore del principio secondo cui solo la Camera poteva giudicare la legittimità dei poteri dei propri componenti. Già in questi primi mesi si era palesato un altro aspetto del D. che ne avrebbe caratterizzato l’azione futura. Il suo tenace moderatismo si esprimeva nella duplice convinzione che “tutti i mali procedono dai movimenti incostituzionali e dalla mancanza di fiducia negli uomini del potere e ogni governo può adempiere alle sue funzioni solo in quanto sostenuto dai rappresentanti della nazione. Nella Camera, riaperta nel febbraio 1849, fece sentire la sua voce affinché la Corona intervenisse contro le “violazioni sistematiche” della costituzione da parte del governo, anche se in precedenza egli stesso aveva contribuito a convincere l’Assemblea ad approvare i tributi imposti dal governo benché questo avesse proceduto senza l’autorizzazione della Camera. Se allora nutriva la speranza di “non vedere più miseramente violato lo Statuto nella sua parte più vitale”, il 28 febbraio, ormai disilluso circa gli intendimenti costituzionali del governo, fu tra coloro che gli negarono la facoltà di riscossione delle imposte.
Sciolto definitivamente il Parlamento nel marzo del ’49 e abbandonata ogni illusione costituzionale, ormai sottoposto ad una sempre più inquietante sorveglianza poliziesca il D. preferì prendere la via di un esilio non troppo disagiato. Scrisse D. Farini nei suoi Appunti sul D.: “Dimorò alcuni mesi a Ginevra. Poi si trattenne principalmente a Parigi ed a Londra, dove la vita elegante non gli fece trascurare gli studi economici e chimici”.
Del soggiorno parigino poco si conosce; resta solo una memoria presentata all’Académie des sciences nel 1855 sull’Electrographie, nouvel art de graver au relief sur métal, una sua invenzione. L’interesse per nuove tecniche di stampa era largamente alla moda; vi si interessava tra gli altri C. Ridolfi, con cui il D. manteneva un’amicizia che risaliva alla partecipazione ai congressi degli scienziati. In Inghilterra, dove giunse alla fine del 1850, fu attentoosservatore delle tecniche e sistemi di conduzione agraria, e delle forme di credito agrario della Scozia, esperienza che poté proficuamente utilizzare nella pratica e negli scritti dopo il ritorno in Italia. Attraverso sir James Lacaita ed Antonio Panizzi poté frequentare uomini politici come Gladstone e Russell, ma prevalentemente l’ambiente degli esuli napoletani già firmatari della protesta di Monteoliveto. Con amici italiani ed inglesi, nel ’59, di fronte al sopraggiungere di altri esuli napoletani, partecipò ad un comitato per raccogliere sottoscrizioni in loro aiuto; e così, insieme a Spaventa, Settembrini e Pica, fu oggetto di “invereconde e basse accuse” di aver distribuito “in parti disuguali le somme raccolte” (G. Massari, Diario …, p. 314).
Dopo il 27 luglio 1860 lasciò l’Inghilterra. Fatta una breve sosta a Napoli, fu a Torino, dove con altri liberali meridionali come Poerio, Scialoja e Pisanelli, cercò di far giungere al governo sabaudo le proprie preoccupazioni per la marcia di Garibaldi, che si presentava inarrestabile. Non fu quindi esteriorità d’occasione la gioia da lui esternata nell’accogliere in Abruzzo re Vittorio Emanuele, il 14 novembre. Poco dopo, era chiamato dal luogotenente Farini a ricoprire la carica di consigliere dei Lavori pubblici. Secondo il giudizio del ministro inglese a Torino, Hudson, tutti i ministri, fra cui il D., “riuscirono tanto inetti quanto il loro capo”. Un simile giudizio espresso da Lacaita sull’azione del D. in questo periodo portò alla rottura della loro amicizia.
Eletto deputato di Atri, nel gennaio 1861, si schierò nelle file moderate, votando l’ordine del giorno Ricasoli sullo scioglimento dell’esercito garibaldino. Profonde convergenze legavano il D. al gruppo dei moderati “campagnoli” toscani. L’attenzione alle pratiche agrarie e all’ammodernamento della conduzione, pur nella conservazione dei tradizionali patti colonici, andava unita, nel D. come nei toscani, all’interesse per le costruzioni ferroviarie, per il compimento più rapido possibile di una rete di comunicazioni nazionali. Già prima del ’48 aveva scritto delle grandi trasformazioni che avrebbero portato le ferrovie in tutta la penisola (Delle strade ferrate italiane, massime per rispetto alle presenti condizioni del Mediterraneo…, in Il Gran Sasso d’Italia, X[1847], 5, pp. 257-286). Ora il deputato D., il 12 giugno 1861, faceva il suo primo importante intervento sul completamento della linea Firenze-Arezzo-Perugia, particolarmente cara agli agrari e finanzieri toscani, che stavano dando la scalata alle imprese ferroviarie. Pur ritenendo che questa linea, per ragioni strategiche e militari, dovesse svilupparsi in direzioni diverse da quelle previste dal ministro Peruzzi, il D. non si discostò dallo schieramento ministeriale. E pochi mesi dopo si sarebbe adoperato, come scriveva a Peruzzi, ad appoggiare i progetti ministeriali cercando di “attenuare la triste sensazione che nelle provincie meridionali dovrà produrre la rinuncia di Talabot” (Acqui, 25 ag. 1861; in Biblioteca naz. di Firenze, cass. XIX, n. 87). Con un apposito opuscolo il D. si rallegrava dell’accaduto, convinto che i ritardi nella costruzione di queste linee fossero dovuti proprio alla società ora rinunciataria (Delle ferrovie dell’Italia meridionale dopo la rinuncia dei concessionari P. Talabot e compagni, Torino 1861, p. 3).
II progetto del D., di affidare la costruzione delle linee a tante piccole società, non incontrava però i favori del gruppo Ricasoli-Peruzzi-Bastogi, che stava per dare vita alla più grande società ferroviaria italiana a prevalente capitale nazionale. Ma le piccole divergenze non potevano minare la comune impostazione culturale di questi proprietari agrari, pronti a fare quadrato per la tutela dei comuni interessi. Esemplare in proposito l’opera del D. sull’emendamento dell’art. 9 dell’imposta di ricchezza mobile, in cui fu sufficiente la soppressione dell’aggettivo “agraria” per riuscire ad esentare i proprietari terrieri dal pagamento della relativa imposta per i redditi provenienti dall’esercizio dell’agricoltura (Nieri, L’emendamento Devincenzi all’art. 9). Anche di fronte al progetto Sella di concedere il servizio di tesoreria alla Banca nazionale sarda – nel 1865 non ancora visto favorevolmente neppure dai Toscani – il D. prendeva una posizione diversa dall’opposizione meridionale schierata contro l’invadenza della banca piemontese, e ammoniva i colleghi a non precipitare “in modo veruno” la questione pur finendo per votare contro. E proprio da un ministero “consorte”, quello Menabrea-Digny, sarebbe venuta il 12 maggio 1868 la sua nomina a senatore.
Attivamente impegnato in diverse commissioni economiche, il D. ricoprì la carica di ministro dei Lavori pubblici due volte. La prima, chiamato da Ricasoli a sostituire S. Jacini, poté fare ben poco, per la breve durata della carica (dal febbraio ai primi di aprile 1867). Ebbe il tempo comunque di stigmatizzare ancora una volta le inadempienze di alcune società ferroviarie e si vide costretto ad ammettere che, se fosse perdurata la presente situazione, “purtroppo” il governo avrebbe dovuto assumerne la gestione diretta. Nel gabinetto Lanza-Sella non ebbe il portafogli alla costituzione del governo, ma in seguito alle dimissioni di Gadda nel 1871.
Sulla sua opera dettero contrastanti giudizi Minghetti, per il quale il D. “aveva portato l’anarchia nei Lavori Pubblici”, e il collega Sella, secondo il quale il D. avrebbe voluto “d’un tratto fare mirabilia”, senza contare gli scarsi mezzi dello Stato. In effetti la sua azione al ministero si distinse per un alacre impegno. Dovette provvedere ai problemi del trasferimento della capitale a Roma, che soli sarebbero stati sufficienti ad impegnare una struttura statale più efficiente e collaudata. Provvide comunque al rinnovo di diverse convenzioni marittime; riformò l’amministrazione centrale del ministero, dividendo la sezione delle acque da quella delle strade; stimolò la bonifica delle zone limitrofe di Napoli; cercò di migliorare i servizi postali e telegrafici. Ma le sue cure principali andarono alla imposizione dell’obbligo di costruzioni stradali ai comuni, ed alla regolamentazione delle concessioni governative alle società ferroviarie. Verso la metà del 1872 aveva ricevuto un voto sfavorevole alla Camera, che aveva mostrato di preferire una linea diretta fra Roma e Napoli attraverso Gaeta, rispetto al miglioramento della esistente via Cassino, come avrebbe voluto il ministro.
Ritiratosi nel ’73 a curare le sue proprietà in Abruzzo, non mancò di partecipare alle più importanti sedute del Senato su materie ferroviarie e sopratutto agrarie. Dal momento in cui si impegnò prevalentemente nella direzione delle proprie campagne, nutrì un sempre più alto concetto della proprietà e dei compiti cui era chiamato il proprietario.
I miglioramenti delle tecniche e delle condizioni di vita nelle campagne erano indilazionabile dovere della classe padronale, non solo per l’utile dell’azienda, ma – condividendo l’insistita preoccupazione dei “campagnoli” toscani – in funzione della pace sociale. Le sue idee, come la sua conduzione, avevano indubbi limiti, sia per il mantenimento in diverse sue proprietà di patti colonici non più adeguati, sia per la stretta unione del processo di produzione agrario e di quello dell’industria degli strumenti necessari. Mise a coltivazione e bonificò gran parte delle sue proprietà abruzzesi; in molte, condotte in proprio, sostituì inizialmente la vite al grano. Per intraprendere tali trasformazioni la proprietà aveva bisogno di larghe anticipazioni, ed a questo proposito avrebbe potuto farsi sentire la benefica, indiretta azione del governo.
L’intervento del D. sull’interpellanza Jacini (1885) – sui provvedimenti che l’autorità intendeva prendere dopo la presentazione dell’inchiesta agraria – rappresenta il compendio del suo pensiero sulla questione che più lo aveva interessato per tanti anni. Si sarebbe dovuto riordinare l’insegnamento agrario, i cui benefici si sarebbero fatti sentire a lungo termine, mentre per il presente si sarebbe dovuto procedere alla riforma del credito agrario. La legge sul credito fondiario varata nel 1866 non aveva dato buoni risultati, e lo stesso Jacini denunciava “le speculazioni che avvenivano fra grosse banche mutuanti e banche popolari”, che facevano pagare il prezzo delle speculazioni agli agricoltori. Di questo tipo di credito, basato su garanzie reali e non personali, avevano potuto approfittare anche proprietari che non avevano poi investito nelle campagne, ed in futuro il governo non avrebbe dovuto affidarlo alle banche di emissione “poiché esse non sarebbero che un pericolo per lo Stato e per la nazione” (Atti parlamentari, Camera, legislatura XV, 10 maggio 1885, p. 3704). L’intervento del D., come già quello di Jacini, rappresentavano il punto finale della sua cultura liberista, proprio mentre ci si accingeva ad accettare un mite dazio come misura provvisoria e “puramente fiscale”.
Liberista sarebbe rimasto negli anni a venire, sia nei principi che ispirarono la Società dei viticoltori italiani (fondata nel 1885), sia per la sua azione nella Società degli agricoltori italiani, cui dette vita nel 1894-95 con Miraglia e Vittorio Stringher. Di questa società, sorta in opposizione alla costituzione di un partito agrario, il D. fu presidente; ne era segretario Ghino Valenti e ne facevano parte protezionisti e antiprotezionisti. Dopo l’entrata in vigore della tariffa dell’87, nelle proprietà condotte in proprio riconvertì le colture da vitivinicole in cerealicole. Con la rotazione sessennale e la semina “sopra sovesci di sulla” ottenne ottimi risultati, che illustrò in uno scritto (Della coltivazione di due poderi…, Roma 1899). Negli ultimi anni di vita, di fronte ai pericoli cui gli sembravano soggiacere le istituzioni, non vide altra via d’uscita se non che il re si “dipart[isse] dalle consuetudinarie forme” e affidasse il governo a personalità di sua fiducia. Tuttavia le preoccupazioni principali continuarono per lui ad essere rappresentate dall’assetto bancario e sopratutto dal credito agrario, su cui presentò ancora una Nota ai Georgofili il 24 giugno 1900.
Morì a Napoli il 1º aprile 1903. Fu sepolto a Lucca nella cappella della famiglia Mazzarosa, un membro della quale aveva sposato l’unica nipote ed erede del D., Maddalena.
Gli scritti del D. sono raccolti nelle Opere complete del senatore Giuseppe De Vincenzi, Ristampa curata e annotata da G. Pannella, I-V, Teramo 1912-1915.
Clicca QUI per visualizzare la scheda da senatore pubblicata sul sito del Senato.